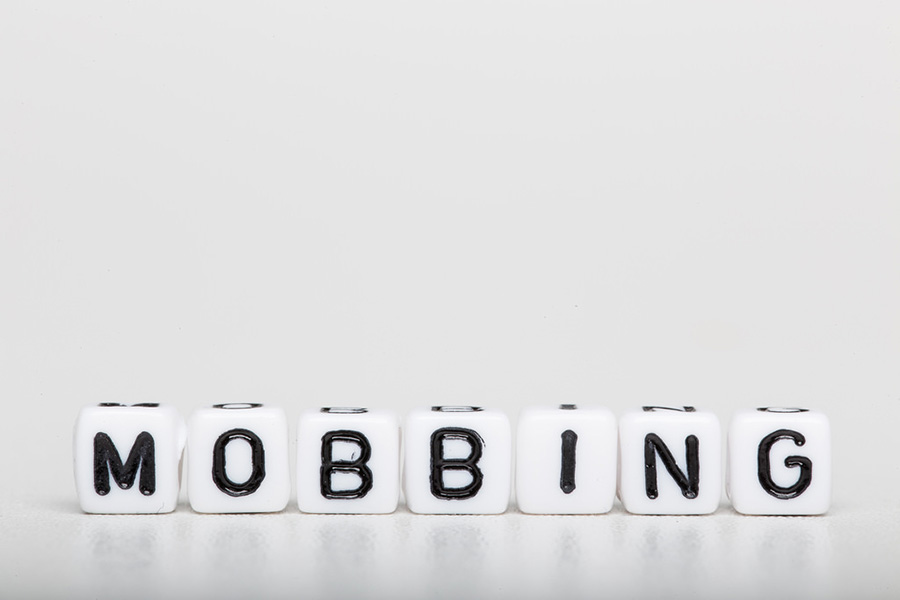 Azioni vessatorie anche non reiterate nel tempo, se provocano un danno alla salute del dipendente, possono fondare l’indennizzo ex art. 2087 del codice civile
Azioni vessatorie anche non reiterate nel tempo, se provocano un danno alla salute del dipendente, possono fondare l’indennizzo ex art. 2087 del codice civile
Quanti lettori saprebbero definire cosa si intende per “straining”? Il termine anglosassone, coniato dal professor Harald Ege, psicologo del lavoro, deriva dall’inglese “to strain” e significa “mettere sotto pressione”. Quando si parla di “straining”, dunque, ci si riferisce ad un grave disagio lavorativo. È la pressione cui viene sottoposto il lavoratore da parte di un superiore o direttamente dal datore di lavoro mediante un comportamento ostile che provoca stress ed effetti negativi nel tempo senza che la vittima possa liberarsi dalla soggezione nei confronti dello strainer. A differenza del mobbing (“to mo”b ovvero assalire, molestare) che prevede una serie di condotte ostili reiterate nel tempo ai danni del lavoratore che provocano un danno alla sua salute come diretta conseguenza delle vessazioni, l’ipotesi di straining non prevede continuità delle molestie nel tempo, ma anche una sola azione che però produce effetti duraturi nella vittima “stressata” come nel caso del demansionamento.
Quest’anno in tema di straining a febbraio e a luglio sono state pubblicate due decisioni della Cassazione che possono aiutare un lettore-lavoratore a comprendere quando si configura e ciò secondo la costruzione dei giudici, i quali hanno come riferimento la disposizione dell’art. 2087 del codice civile per il rispetto dell’integrità fisica del lavoratore che pone a carico del datore-imprenditore l’obbligo di adottare le misure idonee a tutelarla.
La recentissima controversia decisa dalla Cassazione con ordinanza pubblicata il 10 luglio 2018 era stata originata dal ricorso al Tribunale di Roma di una lavoratrice che sosteneva di essere stata vittima di una condotta “mobbizzante” da parte del datore di lavoro, una società per azioni, e chiedeva pertanto la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti anche non patrimoniali. La dipendente chiedeva, inoltre, l’accertamento della responsabilità della società in ordine all’insorgenza e alla prosecuzione di una malattia da cui era affetta che aveva determinato le sue assenze dal lavoro. Il protrarsi della malattia aveva causato il suo licenziamento per superamento del periodo di comporto e, pertanto, costei chiedeva la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra.
Il Tribunale non accoglieva la domanda e anche la Corte di Appello confermava il rigetto per cui la lavoratrice ricorreva in Cassazione, procedimento deciso con l’ordinanza n. 18164/2018. Va elogiata la difesa della lavoratrice che, soccombente in primo grado, in appello, considerando opportunamente le risultanze dell’istruttoria svolta sceglieva la via dell’accertamento dello straining a carico del datore e in sede di legittimità contestava l’inammissibilità della domanda di cui la controparte aveva eccepito la novità, reputando che questa fattispecie poteva definirsi come un mobbing attenuato, ma non per questo non meritevole di tutela risarcitoria per la dipendente. La Corte, accogliendo i motivi di ricorso, ha precisato che lo “straining” è effettivamente una modalità illegittima di atteggiarsi nei confronti del dipendente e, pur non evidenziandosi il requisito della continuità delle azioni vessatorie, in ogni caso gli episodi dimostrati – avendo prodotto un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore (dimostrato dalla consulenza tecnica effettuata in corso di causa) – rientravano nella tutela ex art. 2087 c.c. «norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (Cass. 3291/2016)».
La difesa della lavoratrice, pertanto, non aveva violato il divieto di domanda nuova disposto dall’art. 112 cod. proc. civ. dopo aver qualificato i fatti come ipotesi di mobbing in primo grado e aver paventato in appello una fattispecie di straining. Per la Corte «si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio». Il ricorso è stato accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della domanda della lavoratrice. Sempre in tema di atteggiamenti ostili del datore di lavoro o dei suoi dipendenti nei confronti di subordinati una precedente ordinanza della sezione lavoro della Cassazione, n. 3977 pubblicata il 19 febbraio 2018, aveva deciso una controversia, in cui era parte un dipendente pubblico, qualificandoli come straining. In quel caso una dipendente dichiarata inidonea all’insegnamento era stata assegnata alla segreteria di una scuola pubblica e, dopo che la stessa aveva lamentato la carenza di personale per l’espletamento dei servizi amministrativi, un dirigente scolastico l’aveva privata degli strumenti di lavoro, attribuendole mansioni didattiche, sia pure in compresenza con altri docenti, nonostante l’accertata inidoneità e, per ultimo, l’aveva privata di ogni mansione per cui la lavoratrice era del tutto inattiva. La consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale aveva evidenziato che la condotta illegittima, anche se non mobbizzante, integrava un’ipotesi di straining e la lavoratrice aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento. Il giudice di appello, a seguito di impugnazione del MIUR, rilevava che «non compete al ricorrente la qualificazione medico-legale della fattispecie ritenuta produttiva di danno risarcibile» per cui sostenere per il ricorrente l’ipotesi del mobbing non pregiudica che il giudice all’esito dell’istruttoria possa invece ritenere l’esistenza dello straining.
La Corte di Appello di Brescia ritenne dimostrato il nesso causale fra le condotte denunciate dalla lavoratrice e il danno biologico di natura temporanea, confermando la liquidazione effettuata dal Tribunale sulla base delle indicazioni riportate nella consulenza tecnica espletata.Il Ministero, pertanto, ha proposto ricorso in Cassazione, successivamente respinto dalla Suprema Corte. In sintesi la sezione lavoro ha evidenziato che non integra violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile fare riferimento alla “nozione medico-legale dello straining anzichè quella del mobbing” perchè lo straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie”, azioni che se si dimostri abbiano prodotto un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 codice civile. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore prevede che costui eviti qualsiasi “condotta che sia finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona”.
Infine la Corte ha aderito alla decisione del giudice del merito per cui era stata dimostrata la responsabilità del Ministero in quanto la dipendente era stata oggetto di azioni ostili, descritte e provate nel giudizio di primo grado, “consistite nella privazione ingiustificata degli strumenti di lavoro, nell’assegnazione di mansioni non compatibili con il suo stato di salute ed infine nella riduzione in una condizione umiliante di totale inoperosità”. Conclusivamente la categoria giuridica dello straining quale “mobbing attenuato” potrà assumere nel tempo contorni sempre più delineati grazie all’elaborazione giurisprudenziale e rappresentare la possibilità per il lavoratore di veder accolta la propria domanda risarcitoria nelle ipotesi certamente prevalenti in cui non si configuri la condotta vessatoria reiterata nel tempo ai suoi danni da parte del datore.